|
Occorre partire dal concetto
che il Matrimonio non era un fatto privato ma una Cosa Pubblica
Specialmente se si trattava
di famiglie di alto rango
L’iter giuridico matrimoniale si
articola in tre fasi principali
- Accordo privato preliminare
- Fidantie o pacta sponsalia
- Matrimonium o subarratio
Poiché il matrimonio richiedeva spese consistenti
e passaggi di denaro e beni di una certa entità, alcuni benestanti , ma soprattutto i poveri, ricorrevano ad uno strattagemma.
LE ETA' DEGLI SPOSI
L’età media della sposa poteva variare
dai 14 anni al 18 a seconda della famiglia. Usualmente venivano date in spose appena si presentava
il ciclo mestruale che già allora si sapeva che era segnale della fertilità della donna. Prima del XVI secolo ci sono spose
giovanissime di addirittura 12 anni come ci testimoniano i testi teatrali e letterari. Questo perché la vita media era breve
e si riteneva che una donna tanto più giovane era, tanto più resistente alle fatiche del parto e fertile sarebbe stata in
futuro.
Il marito in media poteva avere dai 10
anni in su più della sposa essendo doveroso che questi fosse dotato di grandi beni e una posizione sociale di un certo livello.
Posizione che ovviamente non veniva raggiunta, salvo qualche caso, nella giovinezza ma verso l'età matura che per un uomo
poteva partire dai 25 anni.
|
 |
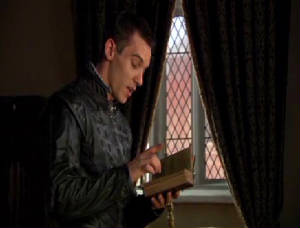
FASE 1- ACCORDO PRIVATO PRELIMINARE
In questa fase venivano condotte le trattative
mediante un mediatore.
Le parti stabilivano e sottoscrivevano
delle condizioni di accordo, insomma la stesura di un contratto.
Curiosità: a Roma questa fase veniva anche
chiamata Abboccamento perché al termine delle trattative i rappresentanti delle due famiglie si stringevano la mano e si baciavano
sulla bocca
Durante le prime due fasi non doveva avvenire
alcun incontro privato tra i due sposi. Tutto doveva essere formale ed alla presenza di parenti e membri della comunità rivolgendosi
rigorosamente col “lei” o col “voi”.
Qualora una fanciulla fosse stata sorpresa
ad incontrarsi in privato col futuro marito ne sarebbe stata minata nell’onore e nella dignità!
Vi sono tuttavia lettere che dimostrano
che alcune donne eran meno sprovvedute di quanto si credesse.
Vi sono “consigli” da parte
di alcune donne, trascritti e tramandati al fine di “imbrogliare ad arte” il mondo maschile e le restrizioni sociali.
Alcuni di questi scritti offrono consigli
, se pur cruenti e qualcuno che farebbe arricciare il naso a chiunque, su come ingannare persino sulla propria verginità affinchè
lo sposo non se ne renda conto e neppure i familiari.
|

